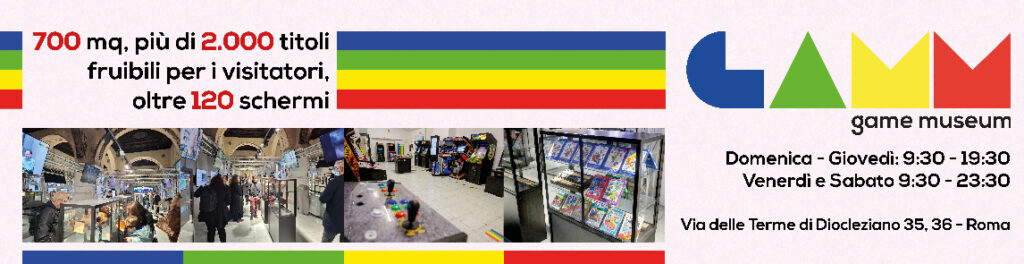Facciamo una piccola premessa: prima di andare al cinema a vedere Gravity, l’ultima pellicola di Alfonso Cuarón, ho sentito molto vociferare su quanto fosse importante l’implementazione del 3D per la sua piena godibilità. Ma solo una volta seduto in sala davanti al film, equipaggiato con i miei scintillanti occhiali 3D ho capito quale fosse veramente il valore aggiunto della tecnologia in questo film.
Facciamo una piccola premessa: prima di andare al cinema a vedere Gravity, l’ultima pellicola di Alfonso Cuarón, ho sentito molto vociferare su quanto fosse importante l’implementazione del 3D per la sua piena godibilità. Ma solo una volta seduto in sala davanti al film, equipaggiato con i miei scintillanti occhiali 3D ho capito quale fosse veramente il valore aggiunto della tecnologia in questo film.
Immersione: ecco la parola chiave. Questo termine che da solo vuol dire tutto e niente è da declinarsi in un modo molto preciso in questo contesto. Immedesimazione è “essere lì”; è rompere più barriere possibili tra la realtà e la finzione per andare a toccare nuove corde dell’emotività umana che mai fino ad oggi, per ovvi motivi di “evoluzione” del media, sono state prese in considerazione. Nel caso di Gravity, questi intenti sono accennati e in parte riusciti, dalle scelte registiche e dal contesto in cui si svolge la storia. Partiamo da quest’ultimo: lo spazio. L’universo stellato che si disperde a vista d’occhio di fatto, annulla qualsiasi percezione delle distanze. Ma basta inserire alcuni elementi “tangibili” che svolgano la funzione di landmark, come un satellite, il pianeta Terra sullo sfondo, una struttura della NASA “all’orizzonte”. Ecco che cosi lo spazio siderale, nella sua asettica, onesta e cristallina povertà di punti di riferimento, acquista con poco una profondità percepibile ben superiore a quanto sperimentato precedentemente in pellicole che utilizzassero lo stesso espediente visivo. In fondo, potremmo semplicemente chiederci, quale ambiente migliore per osservare “quanto lontano possiamo vedere grazie al 3D” se non l’universo infinito? E quanto potrebbe esponenzialmente essere superiore la suggestione e l’esperienza di “giocare all’astronauta” con Oculus Rift? A mio avviso, molto.
 Ovviamente ogni considerazione può essere vista come mera congettura o fantasiosa ipotesi, non essendo mai stato io nello spazio. Ma provate a pensarci, Oculus Rift ti costringe a un isolamento fisico e sensoriale, non dissimile da quello che dovrebbe trasmettere la tuta degli astronauti che, almeno in situazioni di spazio aperto, esattamente come il nostro visore 3D, non offre alcun feedback esterno se non quello visivo (e uditivo) filtrato dall’equipaggiamento indossato.
Ovviamente ogni considerazione può essere vista come mera congettura o fantasiosa ipotesi, non essendo mai stato io nello spazio. Ma provate a pensarci, Oculus Rift ti costringe a un isolamento fisico e sensoriale, non dissimile da quello che dovrebbe trasmettere la tuta degli astronauti che, almeno in situazioni di spazio aperto, esattamente come il nostro visore 3D, non offre alcun feedback esterno se non quello visivo (e uditivo) filtrato dall’equipaggiamento indossato.
Altri due elementi del film, mi hanno fatto riflettere sulla potenzialità dell’esperienza “un viaggio nello spazio” nel passaggio film – realtà virtuale/videogioco: e sono la prospettiva e la continuità visiva. Nel film si tenta sovente di aggirare queste due limitazioni congenite del media legato indissolubilmente alla propria natura narrativa, per venire incontro alle esigenze atmosferiche di cui sopra. Chi ha visto il film avrà notato sicuramente un montaggio veramente generoso di piani sequenza: scene piuttosto lunghe infatti vedevano ruotare la telecamera, ora per avvicinarsi ora per allontanarsi o cambiare soggetto, senza stacchi di sorta, quasi a favorire una sorta di fruizione contemplativa, fluida, dal ritmo rilassato e di conseguenza, verosimile. È possibile così immedesimarsi in questa situazione al di fuori della spazialità e del tempo, prima di quello stacco, quel cambio scena, quel primo piano che spezza l’illusione e riporta il focus del film alle vicende dei due sfortunati personaggi di Clooney e Sandra Bullock.
Con Oculus Rift, si prospettano esperienze in cui la continuità visiva sia tenuta in seria considerazione, un po’ come succede in molti giochi di questa generazione in cui si tenta un’esperienza diversa dal “film interattivo” (attenzione,considero il punto di vista registico, non ludico). Mi viene in mente a tal proposito, e sempre per rimanere in tema “stellare”, Dead Space, in cui le scene giocabili e i dialoghi (o comunque le sequenze passive per il giocatore) erano legate tra loro senza soluzione di continuità. Banale certo, ma fondamentale per regalare il punto di vista più intimo e personale di un viaggio o un’esperienza. Altrettanto banale ma non per questo scontata, è la prospettiva.
C’è una scena in Gravity, e solo una, in cui per una volta entriamo negli occhi della protagonista, all’interno della navetta spaziale che dovrebbe portarla in salvo, privi di gravità, cercando insieme a lei di orientarci velocemente mentre percorriamo il lungo corridoio della struttura orbitante, cercando di immaginare cosa si prova e quale sarebbe il nostro punto di vista se l’artificio fosse realtà. L’assistenza del 3D e della visuale in prima persona scelta per questa particolare sequenza, aiutano a visualizzare nella nostra mente le ipotetiche sensazioni che ognuno di noi in base alla propria soggettività materializzerebbero in tal situazione.
 Ecco, mentre guardavo Gravity pensavo a quanto i punti forti della tecnologia Oculus Rift siano i punti deboli della struttura del film, che non per colpe, ma per genetica diversità espressiva, può tentare la strada solo timidamente, nonostante gli espedienti registici e le tre dimensioni. Prospettiva, continuità visiva, profondità e illusione della realtà che ti circonda, sono tutte suggestioni appena percepite in Gravity che troverebbero piena espressione con Oculus Rift.
Ecco, mentre guardavo Gravity pensavo a quanto i punti forti della tecnologia Oculus Rift siano i punti deboli della struttura del film, che non per colpe, ma per genetica diversità espressiva, può tentare la strada solo timidamente, nonostante gli espedienti registici e le tre dimensioni. Prospettiva, continuità visiva, profondità e illusione della realtà che ti circonda, sono tutte suggestioni appena percepite in Gravity che troverebbero piena espressione con Oculus Rift.
Insomma, da videogiocatore, mi chiedo, quanto sarebbe bello un videogioco su Gravity? O in generale sullo spazio infinito?
Così lontano dalla nostra realtà da ammaliare, ma cosi reale da essere plausibile. Unire armoniosamente tutte le peculiarità descritte poc’anzi e coadiuvate dal tratto distintivo che separa definitivamente lo spettatore dal giocatore: il libero arbitrio. Quello che ti permette di essere padrone del tuo panorama, quello che ti permette decidere quando e se interagire con qualcosa o qualcuno.
 Una prospettiva affascinante non c’è che dire, che ovviamente non ha destato interesse solo nel sottoscritto ma che coinvolge già gli sforzi produttivi di alcuni programmatori alle prese con Oculus Rift. È il caso di Robert Hodgin, che proprio ispirato dal film ha voluto subito sperimentare concretamente gli impieghi pratici di questa visione. Quello che ne è venuto fuori è una simulazione dello spazio a onor del vero tecnicamente ancora grezza, i cui margini di miglioramento sono notevolmente ampi.
Una prospettiva affascinante non c’è che dire, che ovviamente non ha destato interesse solo nel sottoscritto ma che coinvolge già gli sforzi produttivi di alcuni programmatori alle prese con Oculus Rift. È il caso di Robert Hodgin, che proprio ispirato dal film ha voluto subito sperimentare concretamente gli impieghi pratici di questa visione. Quello che ne è venuto fuori è una simulazione dello spazio a onor del vero tecnicamente ancora grezza, i cui margini di miglioramento sono notevolmente ampi.
Ovviamente per riuscire appieno servono risorse produttive ingenti e bisogna necessariamente superare lo scoglio della bassa risoluzione della prima generazione di dispositivi Oculus. Ma le potenzialità sono evidenti e il fatto che già siano in corso ricerche per imboccare la strada giusta, è un ottimo segno.
 A me è piaciuto Gravity (il film), ma lo ammetto, più perché l’ho visto con gli occhi del videogiocatore che quelli del cinefilo. E non per i discutibili meriti della sceneggiatura ma per aver fatto appello al mio animo più sognatore, il più curioso, affamato di provare cose che non si possono provare, voglioso di giocare con tutte le percezioni e sensazioni possibili.
A me è piaciuto Gravity (il film), ma lo ammetto, più perché l’ho visto con gli occhi del videogiocatore che quelli del cinefilo. E non per i discutibili meriti della sceneggiatura ma per aver fatto appello al mio animo più sognatore, il più curioso, affamato di provare cose che non si possono provare, voglioso di giocare con tutte le percezioni e sensazioni possibili.
Forse Oculus Rift si rivelerà la piattaforma creata da chi “sogna” per chi “sogna”, è ancora presto per dirlo. Ma anche se trovo fuori da ogni razionalità sperare che un giorno galleggerò leggero davvero in mezzo allo spazio infinito, questa speranza, mi concedo ancora di conservarla.
Davide Salvadori
Clicca sulla copertina per leggere