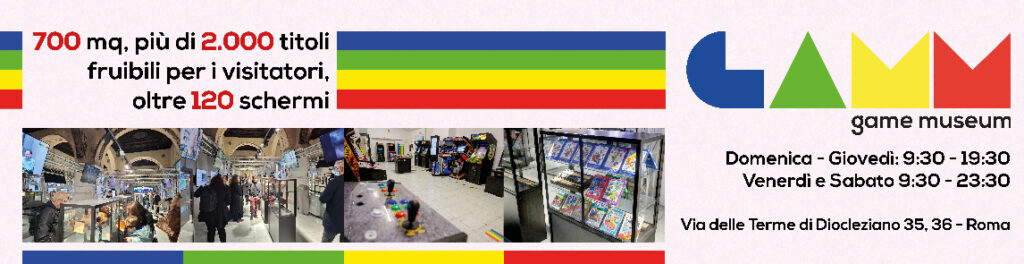Un articolo di Gamerant ha portato alla mia attenzione una ricerca del Pew Research Center, un’organizzazione no-profit che esplora ogni genere di argomento attraverso sondaggi d’opinione. I risultati riportati da Maeve Duggan dimostrerebbero che, seppur la metà degli statunitensi si diletti coi video game, solamente un misero 10% è propenso ad accettare l’etichetta di “gamer“. Essendo una statistica di oltre oceano, verrebbe naturale pensare sia ben poco applicabile alla realtà nostrana, ma la fascinazione dell’Italia nei confronti dei media americani ha forgiato diversi personaggi “orientati positivamente verso i consumi” con il risultato che il 43% degli italiani ha spesso una consolle accesa in casa. Come mai questa discrepanza significativa nei numeri, quindi?
La spiegazione è semplice: l’immagine del nerd, apparentemente rivalutata negli ultimi anni, risulta invece ancora macchiata da forti pregiudizi grazie a una “moralità” degna del più becero programma di Barbara D’Urso. Che si stia parlando dei giocatori occasionali di Pro Evolution Soccer o di coloro che passano intere giornate a perdere tempo su Candy Crush, la cosa cambia poco, resta un grosso imbarazzo nel dover ammettere pubblicamente di sollazzarsi con quell’intrattenimento digitale che, almeno nel mondo occidentale, è stato introdotto nel mercato come un vezzo per bambini e, pertanto, inadatto alla vita adulta. La situazione viene ulteriormente esacerbata da un’intricata serie di mala-informazione sostenuta da giornalisti in cerca dei facili consensi di un pubblico di mezz’età un po’ bigotto e da telefilm che non solo non sanno come funzionano i videogames, ma non hanno neppure idea di quanto sia subdolo l’hacking o, peggio ancora, di come si suppone sia usata una tastiera.

Per quanto ci si definisca progressisti siamo ancora ai tempi di Steve Urkel, il “nerd” viene visto come un essere disgustoso e strano fintanto che non aderisce a canoni di prestanza e bellezza di comprovata adesione; la moda del “valorizzare” i nerd parrebbe essere solo superficialità, se si fa un confronto tra Otto sotto un tetto e Big Bang Theory si noteranno certamente alcune affinità non indifferenti nonostante le due decadi che li separano. La cosa tragicomica, a questo punto, è il fare caso come io sia passato fluentemente dal parlare di gamers al discutere di nerd e sono convinto che molti lettori non avranno dato peso alla discrepanza dei due temi, visto che si da comunemente per sottinteso che un gamer sia per forza nerd. Videogiocare è un intrattenimento fine a sé, suggerire che ogni individuo con un controller tra le grinfie venga marchiato indelebilmente dalla mano bianca di Saruman è folle quanto il supporre che un telespettatore di cricket sia caratterizzato da ottime doti sportive. Magari si può intuire sia inglese o che sia nato in una ex-colonia, ma sono misere le possibilità che si dedichi a quell’orribile, orribile sport. Sul serio! Le regole sono senza capo ne coda e i match possono durare per settimane intere, se il clima atmosferico è inclemente; un esempio classico è quello del 1939 quando… no, sto deragliando. Torniamo alla questione principale.
Di contro sono gli “hardcore gamers” che cercano (più o meno volontariamente) di arginare con fare snob l’avvento di nuovi membri alla prestigiosa setta del videogiocatore. Come Gita Jackson aveva fatto notare provocatoriamente in passato, molti utenti reagiscono al concetto espanso di mondo videoludico con la resistenza che ci si aspetterebbe da un popolo invaso da un potente colonizzatore. Se per gli americani il nocciolo della questione è l’avvento di nuove demografiche malamente integrate, le nostre problematiche appaiono decisamente più modeste e innocenti, limitandosi prevalentemente al concetto di cosa possa essere definito come “videogame”. Sono il primo, qui, a battersi il petto e ad ammettere le proprie colpe: più volte mi è capitato di reagire con sdegno nel sentire neofiti elencare FarmVille tra i loro videogame preferiti! Questa forma di paura è naturale, visto che si sta parlando dell’avvento di una crisi identitaria nella quale una classe si ritrova privata dei propri punti di riferimento, ma il mercato si sta allargando per necessità e democrazia, negare la realtà chiudendosi in una formazione a testuggine certo non aiuta.

Mi pare fazioso e ipocrita chiedermi su VMAG se l’aggettivo “gamer” possa avere una connotazione negativa (forse sarebbe più curioso porre il quesito su Pomeriggio Cinque), quindi mi concentro su una prospettiva apertamente più soggettiva e vi chiedo: quali sono i limiti che definiscono l’esperienza videoludica? Le ricerche e il dizionario sono lapidari sulla questione, un gamer è colui che gioca ai videogame nel suo tempo libero, ma evidentemente i diretti interessati sembrano reagire con orrore a questa definizione clinica, reputandola più utile alle pianificazioni commerciali delle grandi aziende, piuttosto che uno specchio della realtà sociale. I videogame, se si accetta il senso esteso del termine, sono tanto variegati da soddisfare ogni genere di carattere; a prescindere dalla territorialità dei veterani, un’atmosfera più aperta e rilassata porterebbe a un’accettazione matura e consapevole della situazione del videogiocatore, ma l’equilibrio tanto ambito pare essere ancora molto distante anche grazie a industrie che, alla disperata ricerca di nuovi clienti, sacrificano con troppa leggerezza gli interessi dei fan per poter puntare a nuove strategie di mercato.
Clicca sulla copertina per leggere