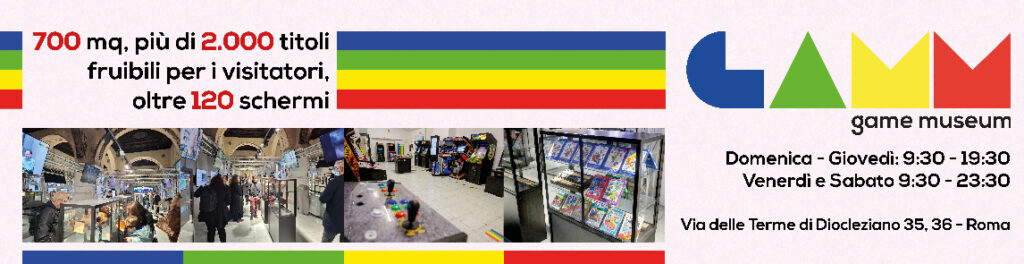Il grande problema dei social network è la poca comprensione delle basi della dialettica. C’è chi usa questa aberrazione in malafede, distorcendo la narrativa a suo favore. È il caso del nostro vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che con la dicotomia “gente comune vs. radical chic” ci ha costruito un’intera carriera politica, additando chiunque esprima dissenso nei suoi confronti di essere un comunista con la villa a Capri, un’insopportabile fallacia retorica che tuttavia per il nostro si traduce in consenso, reaction positive e, in ultima analisi, potere. Se questo scenario vi suona familiare, è perché è il mondo in cui viviamo, e l’echo chamber dei “nerd” (categoria a cui fieramente appartengo) non fa certo eccezione.

Questa retorica dello schieramento, mai aperta al dialogo e impermeabile all’indagine prerogativa del libero pensiero, è, purtroppo, sintomo della perniciosa semplificazione linguistica e concettuale a cui siamo sottoposti giorno dopo giorno, complice l’utilizzo di piattaforme sempre più inclini alla brevità, pensate per una fruizione istantanea e superficiale che è assurta a sentimento del nostro tempo.
Similmente, il dibattito sorto intorno ad Avengers Endgame sui social ha istantaneamente assunto i tratti dello scontro tra la critica “parruccona” e il popolo festante dei cinecomic, in un bizzarro caso di arte che imita la vita, con gli strenui difensori dei fratelli Russo che, vestita la calzamaglia, si sono ritrovati a “combattere” contro i supposti detentori della cultura cinematografica. A ogni costo, appunto.

Il “cinecomic” è un genere indubbiamente divertente. D’altronde, da piccolo mi divertivo con i pupazzetti dell’Uomo Ragno, guardavo i cartoni animati e qualche fumetto l’ho pur sfogliato nel corso della mia vita. Come tutti. Quindi, è dai tempi degli Spider-Man di Sam Raimi che vedere gli eroi dell’infanzia prendere vita sul grande schermo è oggettivamente divertente, un godibile passatempo fanciullesco per staccare il cervello, emozionarsi e, perché no, sognare un po’, come da sempre si sogna al cinema.
Cito non a caso i primi due Spider-Man, a tutt’oggi spettacolari, pieni di effetti speciali e graziati da un interessante lavoro di character development, con il povero Parker chiamato a districarsi tra la vita quotidiana e il difficile mestiere di Uomo Ragno. Una storia familiare, raccontata a un nuovo pubblico, o a un pubblico che, come me, aveva già in qualche modo amato quel setup narrativo.

La mia tesi è che, al di là del monumentale sforzo produttivo, tecnico e mediatico profuso nell’MCU, nulla sia cambiato rispetto ai tempi degli Spider-Man di Raimi. E lo dico nel modo più lusinghiero possibile, per quanto possa sembrare paradossale, o persino offensivo nei confronti dell’epopea Marvel Studios. L’evoluzione linguistica del cinecomic è stata quindi pressoché inesistente: abbiamo solo prodotti tecnologicamente e visivamente più impressionanti, meritevolo di encomio, certo, ma la formula è quella che in tempi non sospetti aveva indovinato Raimi, o persino Tim Burton. Nolan, ovviamente, fa storia a sé, pur rientrando nell’equazione. È normale che la gente si commuova guardando Avengers Endgame, perché oltre a chiudere oltre 10 anni di film richiamando l’infanzia di molti spettatori (io lo chiamo “effetto Toy Story 3”), fa leva su tematiche universali, filtrate tramite l’ottica del popcorn movie disneyficato.
Endgame fa leva su tematiche universali, filtrate tramite l’ottica del popcorn movie disneyficato
I temi di Endgame sono semplici e parlano a tutti: vendetta, sacrificio, fratellanza, bene comune. E ci siamo. La frattura logica si verifica quando tali tematiche, forti e obiettivamente interessanti (seppur necessariamente rimasticate per un massiccio pubblico di moviegoer di bocca buona), diventano il grimaldello per parlare di Avengers Endgame in qualità di capolavoro cinematografico storicamente rilevante, degno di ricevere valutazioni critiche fragorose nel linguaggio e quasi isteriche nel numerino a fondo articolo. No, signori, non ci sto.
Avengers Endgame è per molti motivi un gran bel film-evento, ma non è Grande Cinema. Non confondiamo ciò che è cool ed emozionante con ciò che è Arte, Bello e Sublime, il Mc Donald’s col ristorante di uno chef stellato, perché noi siamo quello che mangiamo. O vediamo. E la colpa di Endgame, se di colpa si tratta, non è ovviamente essere una pellicola di genere, perché il punto non è questo e d’altro canto solo un pessimo critico non riuscirebbe a contestualizzare confondendo le mele con le pere, o i film da Sundance Festival con i cinepanettoni. Ma, se non vogliamo finire vittima dell’egemonia culturale di poche major, dobbiamo imparare a riconoscere le differenze, a esprimere giudizi informati e, soprattutto, a parlare di capolavoro a ragion veduta. E, ve ne prego, stacchiamo il cordone ombelicale dalla rassicurante bolla social a cui apparteniamo, o almeno proviamoci.

La posta in gioco è alta, e farà la differenza nei prossimi anni tra la sopravvivenza della figura del critico e la sua trasformazione in un fanboy poco accorto, un buffo uomo sandwich armato di mouse e tastiera, pagato per riscrivere (magari anche pro bono) quelle poche informazioni codificate che gli vengono cortesemente girate dagli uffici stampa e destinato a cadere periodicamente vittima di una Sindrome di Stendhal indotta ad arte dal battage pubblicitario.
Non credo di essere particolarmente originale nel dire questo: nel mondo dei videogiochi si parla di (non) cultura dell’hype e rapporto tossico redattore-industria da oltre un decennio (ricordo distintamente missive sull’argomento spedite all’indimenticata edizione italiana di Edge, sia su Videogiochi sia su Game Pro, dove invece le vedevo proprio arrivare). Eppure di hype periamo (e feriamo) costantemente. Io stesso stavo per comprare Kingdom Hearts III.
Cadere periodicamente vittima di una Sindrome di Stendhal indotta ad arte dal battage pubblicitario
Il cinema di genere può quindi essere grande cinema? Pur riconoscendo di non avere gli strumenti per trattare adeguatamente la questione, proverò a rispondere umilmente con qualche esempio tratto dalla mia personale esperienza di spettatore. Alien è una storia di genere tra le più basilari e, sulla carta, pericolosamente esposta al ridicolo e ai risolini imbarazzati dei critici “parrucconi”. Un alieno dalla testa fallica che impregna persone su una nave spaziale? Non credo sia questa l’idea di cinema che poteva avere, che so, Ingmar Bergman, e probabilmente il concept è a tutt’oggi ributtante anche per il nostro Nanni Moretti (o è quello che posso immaginare alla luce della famosa reazione di uno dei suoi personaggi alla visione di Strange Days).
Alien diventò grande cinema grazie a una sintesi alchemica irriproducibile, ovvero nel momento in cui avevamo un’interprete memorabile e iconica, la Weaver; un’Artista pazzo, feticista e geniale, Giger; e un duo regista/sceneggiatore che attraverso storytelling visivo e testuale, simbolismi e inquadrature riuscì a raccontare in un film le più ancestrali paure dell’uomo, l’orrore cosmico lovecraftiano, la solitudine, il silenzio di Dio, la casualità insita nella genesi dell’universo e l’idea, terribile, che la natura avesse concepito, in qualche angolo remoto dello spazio, una creatura totalmente priva di empatia e morale, una satanica macchina per uccidere che metteva in discussione ogni velleità di antropocentrismo. Cameron sapeva così bene che nessuno sarebbe mai stato più in grado di evocare quel demone, che pertanto optò per una strada completamente diversa. Che Aliens sia un’alchimia altrettanto irripetibile, poi, è un’altra storia.
L’orrore cosmico lovecraftiano, la solitudine, il silenzio di Dio, la casualità insita nella genesi dell’universo
In Alien persino il ruolo di Jones, il gatto, è un colpo di genio (e no, non parlatemi dell’orrendo felino di Captain Marvel*, per favore). Vorrei essere uno scrittore molto, molto migliore di quello che provo a essere per scrivere degnamente della grandezza di Alien e rendergli così giustizia, ma per ora dovrete accontentarvi del mio seppur genuino entusiasmo. Alien parla di valori, principi, archetipi, filosofia, profondità e complessità, parole forse spaventose in un’epoca che evita la difficoltà concettuale in nome della perpetua Sindrome di Peter Pan di chi si rifugia nell’infantilismo e nella nostalgia patinata, spacciandole per genuino incanto fanciullesco.
*Il discorso sul rapporto tra “advocacy” e cinecomic meriterebbe un post a parte e non è detto che in futuro non ci possa pensare seriamente.
A questo proposito, credo sia emblematico far notare che al cinema per gli Avengers ho visto più ventenni/trentenni che bambini, laddove nelle ultime vacanze di Pasqua ho osservato empiricamente come il parentame in età scolare abbia ormai abbandonato gli amati pupazzetti di Batman e Spider-Man, sedotto dalle sirene digitali di Fortnite e Brawl Stars, ai loro occhi evidentemente più accattivanti. Una rondine non fa primavera, è ovvio, ma il sospetto che i supereroi siano più culturalmente rilevanti per noi, figli mai cresciuti degli anni ’80/’90, che per le nuove generazioni, è legittimo.

Come accade in una bella storia d’amore, sono chimica e alchimia a rendere grande un film, ma i segreti di queste arti, per natura, non possono essere acquistati. Neanche se ti chiami Marvel Studios. Puoi supplire con la pura potenza di fuoco dei più bravi CG artist al mondo, ma nessuno di loro, temo, diventerà mai Giger. Il desolante prosieguo cinematografico di Alien è lì a dimostrarlo, testimonianza che a volte neanche un regista del calibro di Ridley Scott può essere in grado di replicare l’alchimia delle sue stesse opere.
Così come puoi avere una bella sceneggiatura, ma non riuscirai mai a replicare la dinamica padre-figlio vista in Indiana Jones e l’ultima Crociata, nata dal tormento vissuto da Spielberg in quanto figlio di genitori separati, e dalla performance indimenticabile di due giganti riuniti nello stesso film, Sean Connery e Harrison Ford.
E, per quanto adori i Guardiani della Galassia (per la precisione, solo Vol. 2 e solo fino alla scena finale), e lo ritenga l’unico esempio di autorialità all’interno dell’MCU, nemmeno la sua pur godibile soundtrack potrà mai essere paragonata a quella di Jackie Brown o Pulp Fiction. Lo stesso Tarantino è passato dall’essere autore (Le iene) a diventare brand (Django Unchained), una trasformazione passata largamente inosservata perché, neanche a dirlo, parliamo pur sempre di un genio.
Indiana Jones e l’ultima Crociata è, sotto molti aspetti, un cinecomic ante-litteram: nel ritmo, nell’estetica e persino nella sua capacità di alternare con criterio azione e umorismo. Indiana è d’altronde ispirato agli eroi della letteratura pulp, che sono gli antenati dei nostri supereroi. Ma a sorreggere il film c’è una regia innamorata dell’avventura nel suo senso più puro, uno script che trasuda passione per la parola scritta a ogni lettera (va detto che l’adattamento italiano è, come in molti film dell’epoca, eccelso), e un Autore che fa della pellicola lo strumento per parlare dei valori a lui più cari, ossia famiglia, religione e spiritualità, giocando con la Storia e con un certo gusto per il motteggiare intellettuale. Ah, e i cattivi sono i nazisti. Potete anche solo immaginare qualcuno più malvagio e spaventoso di Adolf Hitler? Provateci.

Si può fare grande cinema di genere, ma è una strada difficile perché, banalmente, non paga. Blade Runner 2049 è stato un insuccesso commerciale, esageratamente di più se paragonato agli incassi degli Avengers, pur essendo un film di fantascienza profondo, visivamente maestoso, cerebrale ed emozionante (e infatti, alle sue spalle, c’era un autore come Villeneuve, nonché l’ombra di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema).
La piattezza intellettuale (incolpevole e legittimamente trascurabile agli occhi dei più, per carità) degli Avengers è disarmante di fronte alla forza di Blade Runner 2049, e parliamo in entrambi i casi di film sci-fi dove l’aspetto visivo spettacolare è importante. Si è del resto provato a mettere i supereroi in mano agli autori (Il cavaliere oscuro di Nolan), e il mondo è andato in visibilio: furono i record di Batman al botteghino a convincere le major della bontà dell’idea stessa di cinecomic, non scordiamolo.

Ma mi chiedo come sarebbe accolto oggi un The Dark Knight. E la risposta, temo, non mi piacerebbe. Lo stesso Avengers poteva essere qualcosa di più: il primo episodio, diretto da un ottimo autore come Whedon, è un bellissimo esercizio di scrittura che prova a immaginare cosa succederebbe se uomini, mostri e divinità (freak, se vogliamo) si incontrassero a bordo di una fortezza volante, setup minimalista degno dei migliori episodi della serie classica di Star Trek.
E io il “vulvetta lamentosa” di Loki, riferito a Vedova Nera, non lo dimentico, sospirando di fronte a un guizzo linguistico e narrativo che si è andato completamente perdendo di film in film, solo per recuperare tutto in corner con l’all-in emotivo di Infinity War, che obiettivamente giocava con i cheat dimezzando l’intero universo nel finale e sacrificando personaggi impossibili da non amare come lo Spider-Man interpretato da Tom Holland. “Azzecca fine e inizio e nessuno si preoccuperà di quello che c’è in mezzo” è una regola nota anche al più umile dei videomaker, e figuriamoci se non è conosciuta anche in casa Marvel.

Non serve scomodare Lars Von Trier, quindi, per mettere in risalto la pochezza spirituale e contenutistica di un seppur ottimo blockbuster come Avengers Endgame, che in fin dei conti ha l’unico difetto (nonché motivo per cui mi trovo a scrivere questo post) di essere stato definito “capolavoro immortale” da persone che, social e tastiera alla mano, si comportano come l’incauto Mickey Mouse apprendista stregone, che ruba il cappello del mago in Fantasia finché il sortilegio non gli sfugge di mano. Sappiamo tutti com’è andata a finire.

Il segreto alchemico alla base del “capolavoro” non potrà mai essere spiegato ai non iniziati, probabilmente. Il critico però, forse, può intuirlo con molta attenzione ed esperienza e, qualora ci riesca, ha il dovere morale di fare luce su quello che luccica come oro, perché è oro, e quello che, invece, è un seppur seducente golem, pietra inerte che scimmiotta pateticamente la vita, svilendo la scintilla creatrice del logos.
È lo stesso motivo per cui Wonderwall non sarà mai Hey Jude. Chi non ci arriva, mi duole dirlo, soffre di un serio e inquietante deficit culturale. Ma io, nella vita, sarò sempre quello che, mentre un cicisbeo in spiaggia strimpella gli Oasis sulla chitarra, si alzerà, metterà le cuffie e farà partire Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club Band. E sapete una cosa?
Sarò sempre fiero di esserlo.
Clicca sulla copertina per leggere